IL CONSENSO, SEMPLICE COME PRENDERE UNA TAZZA DI THE (?)
- Tina Noto
- 7 set 2017
- Tempo di lettura: 4 min
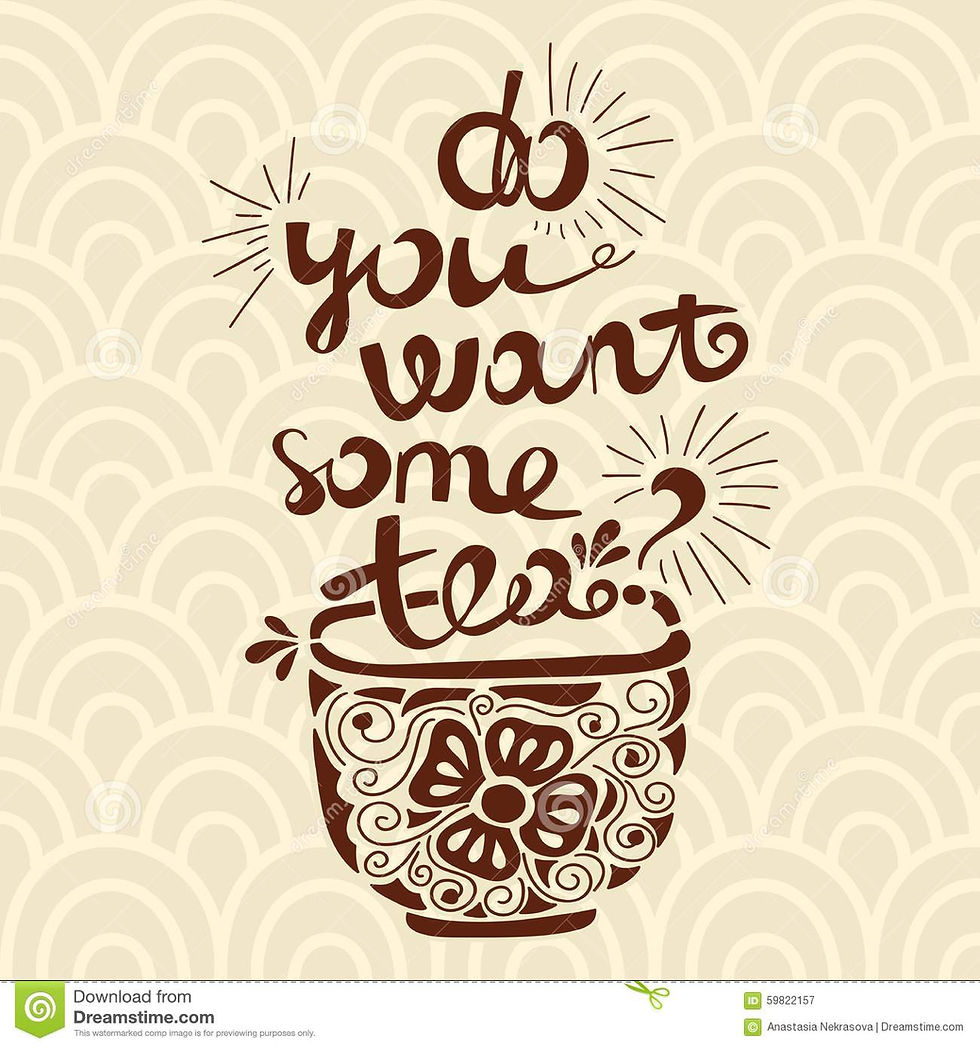
Il titolo, nonché il contenuto, di questo contributo può apparire bizzarro, se non addirittura sganciato dal contesto “squisitamente” giuridico di Legal Advice in Italy.
Tale scelta muove da una lettura alquanto semplificata, ma al contempo sagace, del concetto di consenso operata da un gruppo di educatori, i Blue Seat Studio, la cui mission è proprio quella di educare con lo humor. In uno dei loro video viene descritta la scena in cui i protagonisti offrono o ricevono una tazza di tè per evidenziare come le dinamiche del consenso seguano per sommi capi le stesse logiche della scenetta di vita descritta.
In un articolo di Freeda (nuovissimo progetto editoriale rivolto alle donne, ma non solo, laddove Freeda, per le fautrici del progetto, “significa freedom al femminile – di fare, di essere, di pensare, in una prospettiva di piena auto-determinazione”) si prende spunto dalla suddetta impostazione educativa per approfondire un tema, quello del consenso, tanto controverso quanto semplice come prendere una tazza di tè.
Per l’appunto, l’articolo rilancia il contenuto del video dei Blue Seat Studio, in cui ci invitano ad immaginare di offrire a un’altra persona una tazza di tè e – ne riporto fedelmente un estratto - “se ci risponde di sì allora possiamo attenerci alla volontà che ha espresso e iniziare a preparare una tazza di the. Una volta pronta, però, potrebbe accadere che a quella persona non vada più di berla, forse perché non le piace o perché ha cambiato idea. Ecco, in questo caso, anche se potrebbe darci fastidio il fatto di aver speso del tempo a preparare il tè, non abbiamo alcun diritto di costringerla a berlo ugualmente, ma, anzi, dobbiamo assicurarci che non si senta in dovere di berlo contro la sua volontà. Potrebbe poi capitare che la persona con cui vorremmo bere il tè non sia cosciente: non essere coscienti vuol dire non poter cogliere il senso della domanda “vuoi del tè?” e quindi non poter esprimere la propria volontà. Risultato: una persona incosciente deve essere lasciata in pace e non essere costretta a bere del tè. Oppure, potrebbe succedere che la persona che all’inizio ci ha detto “sì, grazie” diventi incosciente qualche minuto dopo aver espresso la sua volontà, e, di nuovo, l’unica cosa che possiamo fare noi in questa situazione (visto che non abbiamo la certezza che voglia ancora il tè) è non costringerla a bere il tè che abbiamo preparato”.
Possiamo chiederci: qual è il legame tra la tazza di tè, il concetto di consenso ed il mondo del diritto?
Dalla definizione fornita dal vocabolario on line Treccani, consenso è conformità di voleri. Tuttavia è proprio in ambito giuridico che siffatto concetto è stato recepito, pensato, rielaborato ed adattato, informando, talvolta, grandi settori degli ordinamenti giuridici odierni. Nel diritto civile, il consenso assume un ruolo primario in ambito negoziale costituendo elemento essenziale, tra gli altri, del contratto, ad esempio; ancora, la legge italiana regola gli atti di disposizione del proprio corpo basandosi sul principio del consenso, con le dovute limitazioni; in diritto penale, il consenso dell’avente diritto costituisce una causa di giustificazione di una condotta che, di per se stessa, si potrebbe configurare come reato.
È con riferimento alla medicina ed alle scienze giuridiche applicate ad essa (il Biodiritto) che il consenso dell’individuo, del paziente, ha ricevuto una speciale attenzione.
Come risposta ai crudeli esperimenti nazisti acclarati nel corso del processo di Norimberga, il consenso, informato, di un essere umano è stato definito come assolutamente essenziale (v. la voce “Informed consent”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy).
A partire dagli anni ’70, le scienze bioetiche e la medicina superano il forte paternalismo che aveva caratterizzato la relazione clinica per oltre duemila anni, in favore della predominanza della autonomia del paziente che proprio sul concetto di consenso affonda le proprie radici.
In ambito medico, e da un punto di vista concettuale, la presenza di un consenso informato prestato dal paziente rappresenta il requisito che rende legittimo l’intervento del medico.
In Italia, l’art. 32 della nostra carta Costituzionale sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se non per disposizione di legge, nel rispetto del principio di autodeterminazione dell’individuo. Dunque, nel nostro ordinamento, il consenso informato consiste in un’autorizzazione del paziente a ricevere un trattamento sanitario previa informazione sul caso da parte del personale sanitario. Il paziente, esercitando il diritto di conoscere tutte le informazioni sulla propria salute (così come, per converso, ha il diritto di non essere informato, se lo ritiene) avendo facoltà di chiedere all’esercente la professione sanitaria, può scegliere se sottoporsi o meno ad un determinato trattamento o esame diagnostico.
Nell’ordinamento penale, l’omesso consenso non è reato. Tale circostanza è però perseguibile civilmente e darà luogo ad un risarcimento danni per vizio del consenso e inadempimento contrattuale.
Per concludere, esistono delle eccezioni all’obbligo del consenso:
- come già rilevato, il caso in cui il paziente abbia espresso la volontà di non essere informato;
- condizioni gravi e pericolose per la vita del paziente che richiedano un intervento di necessità e urgenza;
- Trattamenti sanitari obbligatori (TSO).

Commenti